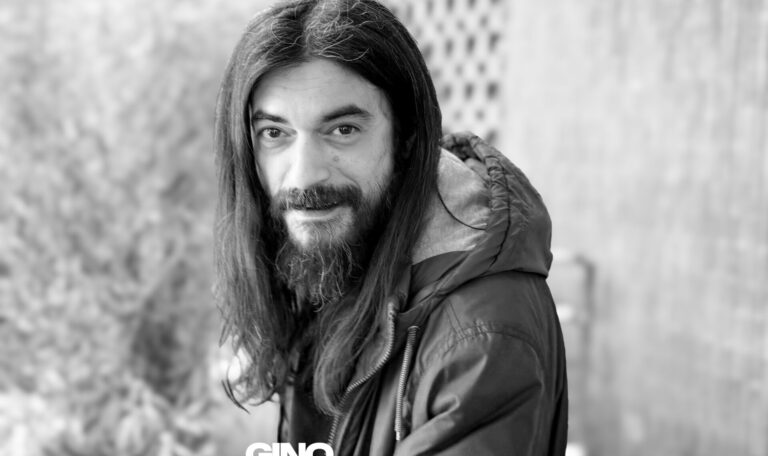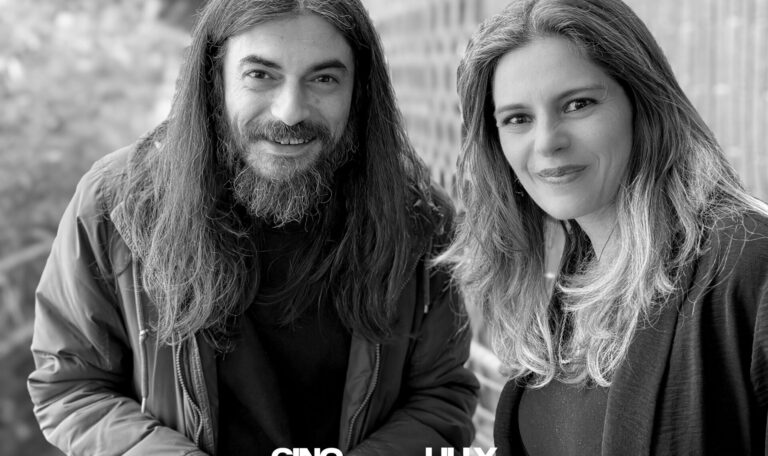Archivio Categoria: Photo Gallery
Photo Gallery
Diane Arbus: uno sguardo etico sulla marginalità
Origini e formazione Diane Arbus, nata Diane Nemerov il 14 marzo 1923 a New York, [...]
05
Ago
Ago
Non tutte le strade portano al mare.
Non tutte le strade portano al mare. Alcune finiscono nel cuore di una giungla, dove [...]
12
Giu
Giu
Roma, 1976: il momento prima che tutto accadesse. Pino Daniele Terra mia
Qualche settimana fa, con Barbara Napolitano, ho avuto l’onore di lavorare al concerto tributo per [...]
31
Mag
Mag
Un caffè alla Rai… con Stefano Sarcinelli. E no, non è uno sketch.
Ci sono persone che ti sembra di conoscere da sempre, anche se non le hai [...]
23
Mag
Mag
GINO FASTIDIO e la posa del supereroe stanco (ma coerente)
MyRaiFriends, episodio GINO FASTIDIO e la posa del supereroe stanco (ma coerente)”. A Gino gli [...]
19
Mag
Mag
Lilly Viccaro Theo, myraifriends
Ci sono colleghi con cui condividi ogni giornata di lavoro, scambi due chiacchiere davanti al [...]
19
Mag
Mag