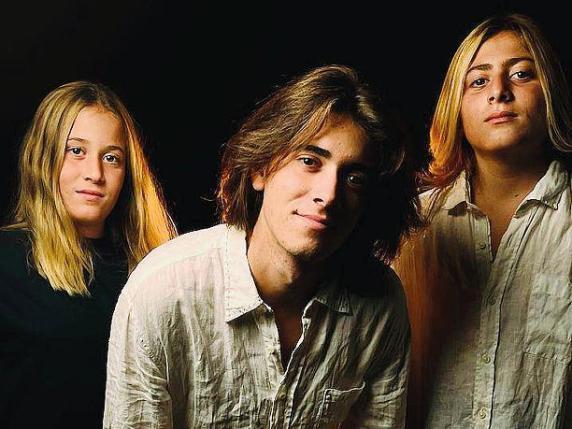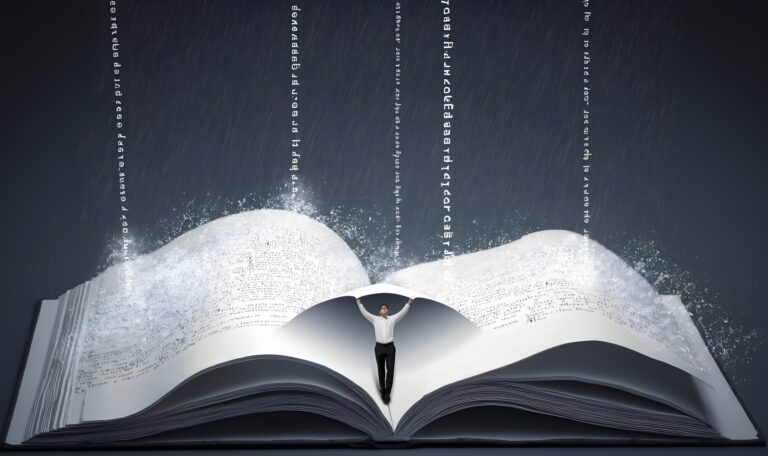Archivio Mensile: Giugno 2025
Léa Moreau ed Echoes: quando la memoria diventa resistenza
di Felice Iovino Non sempre si inventa un personaggio. A volte è il personaggio che [...]
27
Giu
Giu
I Sonic Rootz e l’adolescenza che suona forte
Ieri sera ho assistito a qualcosa che mi ha profondamente colpito. Sul palco c’erano tre [...]
20
Giu
Giu
Non tutte le strade portano al mare.
Non tutte le strade portano al mare. Alcune finiscono nel cuore di una giungla, dove [...]
12
Giu
Giu
Il Coraggio di chiamarla per nome
E’ fragile come un bambino sempre in pericolo, sempre sotto attacco, perché è più facile [...]
12
Giu
Giu
Come si impara a non vedere
Mi hanno insegnato ad avere pazienza.A non disturbare il potere mentre esercita se stesso.A non [...]
08
Giu
Giu
Useless Mission: Io, Cecilia, una chitarra e un tetto.
Il video che sto per riproporre l’avete già visto.Magari vi è passato davanti distrattamente, magari [...]
08
Giu
Giu
- 1
- 2