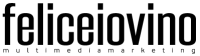Ci sono idee che nascono per gioco… e finiscono per diventare qualcosa di molto più grande.
Per il compleanno di Valentina, ho deciso di coinvolgere l’intera redazione della TGR Campania – giornalisti, tecnici, montatori – in un piccolo esperimento di follia collettiva. L’obiettivo? Farli ballare. E lo abbiamo fatto davvero!
Tra una battuta e un passo improvvisato, tra smorfie, risate e piccole scene surreali, è nato un video che abbiamo proiettato tutti insieme. Il risultato? Un’esplosione di allegria, abbracci sinceri e quella bellissima sensazione di sentirsi parte di un gruppo vero, umano, vivo.
Questo video è molto più di un semplice augurio: è un inno alla leggerezza, alla complicità, al piacere di stare insieme anche fuori dagli schemi del lavoro.
E quando si riesce a ridere, a ballare, a non prendersi troppo sul serio… si scopre un’energia contagiosa, che unisce e fa bene all’anima.
Grazie a tutti per aver reso questo momento così speciale.
E a te, Vale, ancora tantissimi auguri: per tutto ciò che sei, per il sorriso che porti e per la bellezza che ci fai condividere. 💙
Con affetto,
Felice