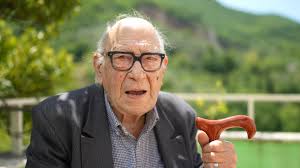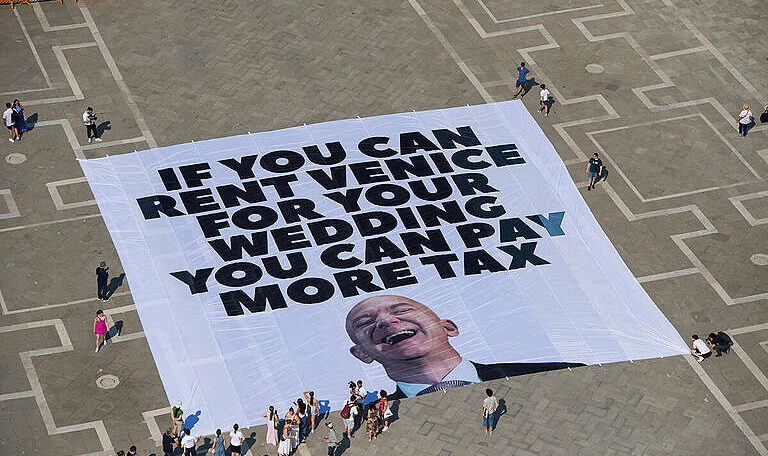Archivio Mensile: Agosto 2025
Infanzia sotto il fascismo: la storia di Rodolfo Valentino Pinna tra Asmara e Fiume
Rodolfo Valentino Pinna, oggi ultranovantenne, condivide una testimonianza preziosa e toccante. Da bambino visse gli [...]
27
Ago
Ago
Sonic Rootz: Desperado
Una sera speciale a Palazzo Reale, il 19 giugno, insieme a Cecilia, Tonino e Cristina, [...]
16
Ago
Ago
Diane Arbus: uno sguardo etico sulla marginalità
Origini e formazione Diane Arbus, nata Diane Nemerov il 14 marzo 1923 a New York, [...]
05
Ago
Ago
Gaza, la denuncia di Greenpeace: “Usare la fame come arma di guerra è un crimine”
Il 30 luglio 2025 Greenpeace Italia ha pubblicato un appello duro sulla situazione di Gaza. Secondo l’organizzazione, [...]
02
Ago
Ago
“Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse”: la protesta che ho visto a San Marco
Nei giorni scorsi a Venezia si è celebrato il matrimonio di Jeff Bezos. La cosa non [...]
02
Ago
Ago