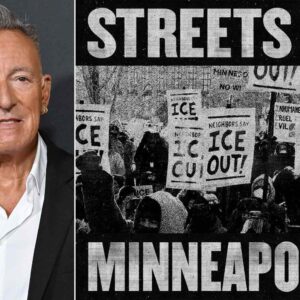Archivio Categoria: Politica
Politica
CRONOLOGIA DI UNA DERIVA
CRONOLOGIA DI UNA DERIVAUn nuovo progetto in episodi.Tanti piccoli momenti. Dettagli che sembravano trascurabili. Episodi [...]
13
Feb
Feb
Bruce Springsteen – Streets Of Minneapolis: quando una canzone diventa atto d’accusa
Il brano racconta una America ferita, osservata dal basso, nelle sue contraddizioni più dure: le [...]
29
Gen
Gen
Marigliano chiama, casa mia risponde col deserto, l’indifferenza e l’odio: cronaca di un abisso culturale.
Ieri sera, nella Sala Consiliare di Marigliano, ho visto qualcosa che mi ha rimesso al [...]
28
Gen
Gen
Roger Waters : Quando non ci si volta dall’altra parte (When you don’t turn away)
Mi ha profondamente commosso ascoltare Roger Waters nell’intervista al Fatto Quotidiano.È stata una sensazione bellissima [...]
25
Gen
Gen
IO SONO IL POPOLO – CALZINI APOCRIFI
Con questo rap nasce la band CALZINI APOCRIFI. E continua il mio diario musicale. Il [...]
10
Gen
Gen
La democrazia sorvegliata
Perché non saremo mai davvero al sicuro C’è una sensazione diffusa che molti provano da [...]
06
Gen
Gen